A Torino non si partecipa
Juri Bossuto 06:30 Giovedì 28 Marzo 2024
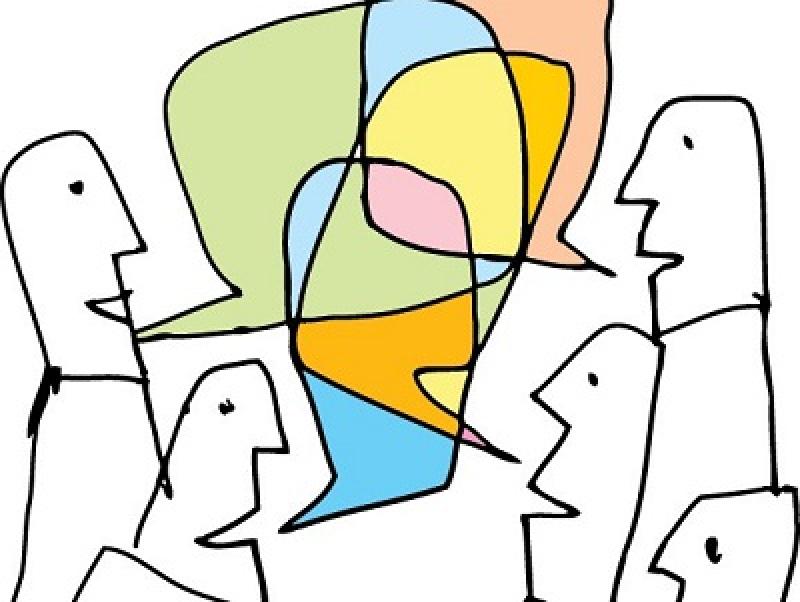 “La libertà è partecipazione”: queste parole, tratte da una celeberrima canzone di Giorgio Gaber, riecheggiano nel vuoto quando si osserva la voragine che oggi (più che mai) separa la politica dalle persone. Una distanza tra elettori ed eletti che cresce di giorno in giorno, grazie anche a una politica costantemente alla ricerca di percorsi utili nel tappare la bocca a chiunque sia in disaccordo con la maggioranza di turno.
“La libertà è partecipazione”: queste parole, tratte da una celeberrima canzone di Giorgio Gaber, riecheggiano nel vuoto quando si osserva la voragine che oggi (più che mai) separa la politica dalle persone. Una distanza tra elettori ed eletti che cresce di giorno in giorno, grazie anche a una politica costantemente alla ricerca di percorsi utili nel tappare la bocca a chiunque sia in disaccordo con la maggioranza di turno.
Diamo pagelle di Democrazia ai governi di mezzo mondo, ma è sempre difficile guardare cosa accade davvero in casa nostra. Dialettica e confronto arretrano davanti all’abituale fretta di chiudere le riunioni assembleari, cosicché evitare quelli che generalmente le giunte ritengono “inutili dibattiti”. Chi vuol “tagliare corto” può contare sempre sul sostegno di un super dirigente, pronto a interpretare le norme regolamentari in modo da non favorire le minoranze.
A Torino, durante una seduta consigliare circoscrizionale, l’opposizione ha presentato oltre 180 emendamenti con lo scopo di costringere la Giunta a cedere quote di autoreferenzialità a vantaggio di tutti i consiglieri. In passato emendare massicciamente una proposta di delibera significava bloccare letteralmente i lavori in aula e, innanzitutto, costringere alla trattativa chi teneva il coltello (immagine metafisica) dalla parte del manico. Tale esercizio di Democrazia è attualmente interdetto dalla lettura “ufficiale” di una norma che legittima il cosiddetto “accorpamento degli emendamenti”: attuato tramite una mozione ideata per mettere insieme il tutto, a prescindere dal contenuto, e superare l’ostruzionismo (ottenuto con lunghi interventi e numerose votazioni “emendamento per emendamento”) affidandosi a una manciata di voti a fine dibattito.
I Consiglieri eletti hanno sempre minor margine di azione politica. Tutti gli atti vengono oramai approvati con delibera di Giunta: discutere un provvedimento in aula è cosa sempre più rara. Il manovratore non vuole essere disturbato, e gioisce quando le riunioni delle commissioni, così come quelle dei consigli, si svolgono in sale deserte, senza pubblico. Ai desolati eletti non rimane che far protocollare interpellanze e mozioni, che di norma vengono portate in discussione mesi dopo il loro deposito: il potere decisorio di come e dove spendere le risorse del bilancio è saldamente in mano a chi governa (della serie “Abbiamo vinto e quini comandiamo!”).
Muore il contradditorio, la capacità di fare sintesi tra opinioni contrapposte e, con esso, la facoltà riconosciuta alle opposizioni di fare la loro parte. I consiglieri non sono i soli costretti al silenzio, poiché la censura riguarda ancor più i cittadini. Il popolo, infatti, in pochi anni ha assistito al tramonto di quella Democrazia partecipata che un tempo era alla base di tanti progetti europei, nonché dei programmi elettorali della Sinistra.
L’accentramento del potere in mano a poche persone rappresenta un pericolo per le comunità: mai come oggi Torino necessiterebbe di un rapporto stretto tra la politica e la cittadinanza. La metropoli subalpina sta attraversando una crisi senza precedenti, forse paragonabile solo a quella esplosa dopo il doloroso abbandono del ruolo di Capitale d’Italia a vantaggio di Firenze (1865). La crisi industriale ha messo in ginocchio il modello produttivo su cui Torino viveva, e grazie al quale espandeva il suo tessuto urbano.
La Fiat ha regnato per anni sulla città pedemontana, condizionando sia le scelte politiche del Consiglio comunale che l’intera comunità (imponendole di fatto i ritmi della fabbrica). Modifiche del Piano Regolatore, contributi, cassa integrazione e accordi segreti con le istituzioni, siglati durante partite di scopa giocate tra il Sindaco e l’Amministratore Delegato in carica, non hanno impedito all’azienda di delocalizzare la produzione altrove. Malgrado il recentissimo spot pubblicitario (che rilancia la storica 500 di casa Fiat) riaffermi l’amore dell’azienda per l’Italia, a Torino non rimane traccia della grande industria fondata dalla famiglia Agnelli.
Attorno allo stabilimento di Mirafiori, a cui si affiancava in passato anche il Lingotto, ruotava un ricco indotto, che rappresentava una forte occasione di impiego per migliaia di lavoratori. Una città nella città si era insediata oltre i cancelli di Mirafiori: città di cui oggi rimane poco o nulla, se non il grande terreno dove sorgeva la fabbrica (ideale per una enorme speculazione edilizia). Stellantis, che ha sede legale all’estero, ha dato recentemente vita a un irritante tira e molla con la nostra città, in cui a volte sembrava volesse investire nuovamente in Piemonte e in altre che si preparasse, invece, a smobilitare anche la poca produzione rimasta. Un gioco cinico terminato quando l’azienda ha dichiarato pubblicamente le proprie intenzioni: smantellare del tutto lo stabilimento di Mirafiori e abbandonare il capoluogo piemontese.
I media sembra abbiano preso coscienza della povertà che inghiotte, giorno dopo giorno, la metropoli subalpina solamente in queste ultime settimane. Finalmente, è stato avviato il computo dei senza tetto, quelli veri (non i truffatori), e di tutti coloro che senza il reddito di cittadinanza non hanno più alcun mezzo di sostentamento: numeri che incrinano ulteriormente la credibilità degli amministratori pubblici.
Le crisi sociali si affrontano attivando percorsi di solidarietà e umiltà istituzionale. Torino, mai come adesso, necessiterebbe di decisioni partecipate, di confronto, anziché del pugno di ferro contro chi non si allinea al volere del potere cittadino. Occorre tornare agli anni in cui Comitati Spontanei e Consigli di Fabbrica partecipavano attivamente alle riunioni circoscrizionali, alle scelte della città.
Dai sogni di partecipazione popolare degli anni ’70, siamo arrivati all’insediamento di nuovi gerarchi: triste destino per la Torino delle lotte operaie e delle rivolte per il pane.


